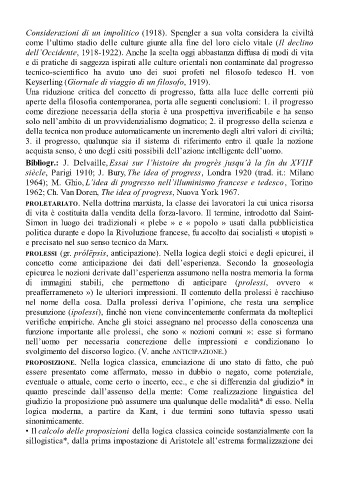Page 677 - Dizionario di Filosofia
P. 677
Considerazioni di un impolitico (1918). Spengler a sua volta considera la civiltà
come l’ultimo stadio delle culture giunte alla fine del loro ciclo vitale (Il declino
dell’Occidente, 1918-1922). Anche la scelta oggi abbastanza diffusa di modi di vita
e di pratiche di saggezza ispirati alle culture orientali non contaminate dal progresso
tecnico-scientifico ha avuto uno dei suoi profeti nel filosofo tedesco H. von
Keyserling (Giornale di viaggio di un filosofo, 1919).
Una riduzione critica del concetto di progresso, fatta alla luce delle correnti più
aperte della filosofia contemporanea, porta alle seguenti conclusioni: 1. il progresso
come direzione necessaria della storia è una prospettiva inverificabile e ha senso
solo nell’ambito di un provvidenzialismo dogmatico; 2. il progresso della scienza e
della tecnica non produce automaticamente un incremento degli altri valori di civiltà;
3. il progresso, qualunque sia il sistema di riferimento entro il quale la nozione
acquista senso, è uno degli esiti possibili dell’azione intelligente dell’uomo.
Bibliogr.: J. Delvaille, Essai sur l’histoire du progrès jusqu’à la fin du XVIII e
siècle, Parigi 1910; J. Bury, The idea of progress, Londra 1920 (trad. it.: Milano
1964); M. Ghio, L’idea di progresso nell’illuminismo francese e tedesco, Torino
1962; Ch. Van Doren, The idea of progress, Nuova York 1967.
PROLETARIATO. Nella dottrina marxista, la classe dei lavoratori la cui unica risorsa
di vita è costituita dalla vendita della forza-lavoro. Il termine, introdotto dal Saint-
Simon in luogo dei tradizionali « plebe » e « popolo » usati dalla pubblicistica
politica durante e dopo la Rivoluzione francese, fu accolto dai socialisti « utopisti »
e precisato nel suo senso tecnico da Marx.
PROLESSI (gr. prólēpsis, anticipazione). Nella logica degli stoici e degli epicurei, il
concetto come anticipazione dei dati dell’esperienza. Secondo la gnoseologia
epicurea le nozioni derivate dall’esperienza assumono nella nostra memoria la forma
di immagini stabili, che permettono di anticipare (prolessi, ovvero «
preafferrameneto ») le ulteriori impressioni. Il contenuto della prolessi è racchiuso
nel nome della cosa. Dalla prolessi deriva l’opinione, che resta una semplice
presunzione (ipolessi), finché non viene convincentemente confermata da molteplici
verifiche empiriche. Anche gli stoici assegnano nel processo della conoscenza una
funzione importante alle prolessi, che sono « nozioni comuni »: esse si formano
nell’uomo per necessaria concrezione delle impressioni e condizionano lo
svolgimento del discorso logico. (V. anche ANTICIPAZIONE.)
PROPOSIZIONE. Nella logica classica, enunciazione di uno stato di fatto, che può
essere presentato come affermato, messo in dubbio o negato, come potenziale,
eventuale o attuale, come certo o incerto, ecc., e che si differenzia dal giudizio* in
quanto prescinde dall’assenso della mente: Come realizzazione linguistica del
giudizio la proposizione può assumere una qualunque delle modalità* di esso. Nella
logica moderna, a partire da Kant, i due termini sono tuttavia spesso usati
sinonimicamente.
• Il calcolo delle proposizioni della logica classica coincide sostanzialmente con la
sillogistica*, dalla prima impostazione di Aristotele all’estrema formalizzazione dei