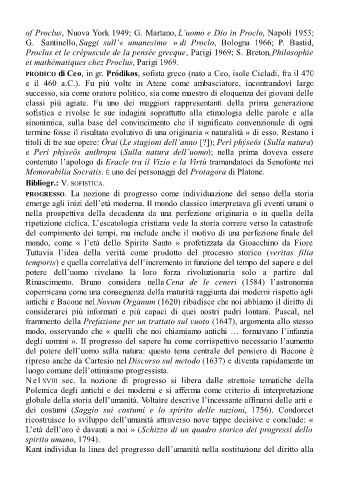Page 675 - Dizionario di Filosofia
P. 675
of Proclus, Nuova York 1949; G. Martano, L’uomo e Dio in Proclo, Napoli 1953;
G. Santinello, Saggi sull’« umanesimo » di Proclo, Bologna 1966; P. Bastid,
Proclus et le crépuscule de la pensée grecque, Parigi 1969; S. Breton, Philosophie
et mathématiques chez Proclus, Parigi 1969.
PRÒDICO di Ceo, in gr. Pródikos, sofista greco (nato a Ceo, isole Cicladi, fra il 470
e il 460 a.C.). Fu più volte in Atene come ambasciatore, incontrandovi largo
successo, sia come oratore politico, sia come maestro di eloquenza dei giovani delle
classi più agiate. Fu uno dei maggiori rappresentanti della prima generazione
sofistica e rivolse le sue indagini soprattutto alla etimologia delle parole e alla
sinonimica, sulla base del convincimento che il significato convenzionale di ogni
termine fosse il risultato evolutivo di una originaria « naturalità » di esso. Restano i
titoli di tre sue opere: Ôrai (Le stagioni dell’anno [?]); Perì phýseōs (Sulla natura)
e Perì phýseōs anthropu (Sulla natura dell’uomo); nella prima doveva essere
contenuto l’apologo di Eracle tra il Vizio e la Virtù tramandatoci da Senofonte nei
Memorabilia Socratis. È uno dei personaggi del Protagora di Platone.
Bibliogr.: V. SOFISTICA.
PROGRESSO. La nozione di progresso come individuazione del senso della storia
emerge agli inizi dell’età moderna. Il mondo classico interpretava gli eventi umani o
nella prospettiva della decadenza da una perfezione originaria o in quella della
ripetizione ciclica. L’escatologia cristiana vede la storia correre verso la catastrofe
del compimento dei tempi, ma include anche il motivo di una perfezione finale del
mondo, come « l’età dello Spirito Santo » profetizzata da Gioacchino da Fiore.
Tuttavia l’idea della verità come prodotto del processo storico (veritas filia
temporis) e quella correlativa dell’incremento in funzione del tempo del sapere e del
potere dell’uomo rivelano la loro forza rivoluzionaria solo a partire dal
Rinascimento. Bruno considera nella Cena de le ceneri (1584) l’astronomia
copernicana come una conseguenza della maturità raggiunta dai moderni rispetto agli
antichi e Bacone nel Novum Organum (1620) ribadisce che noi abbiamo il diritto di
considerarci più informati e più capaci di quei nostri padri lontani. Pascal, nel
frammento della Prefazione per un trattato sul vuoto (1647), argomenta allo stesso
modo, osservando che « quelli che noi chiamiamo antichi … formavano l’infanzia
degli uomini ». Il progresso del sapere ha come corrispettivo necessario l’aumento
del potere dell’uomo sulla natura: questo tema centrale del pensiero di Bacone è
ripreso anche da Cartesio nel Discorso sul metodo (1637) e diventa rapidamente un
luogo comune dell’ottimismo progressista.
Nel XVIII sec. la nozione di progresso si libera dalle strettoie tematiche della
Polemica degli antichi e dei moderni e si afferma come criterio di interpretazione
globale della storia dell’umanità. Voltaire descrive l’incessante affinarsi delle arti e
dei costumi (Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, 1756). Condorcet
ricostruisce lo sviluppo dell’umanità attraverso nove tappe decisive e conclude: «
L’età dell’oro è davanti a noi » (Schizzo di un quadro storico dei progressi dello
spirito umano, 1794).
Kant individua la linea del progresso dell’umanità nella sostituzione del diritto alla