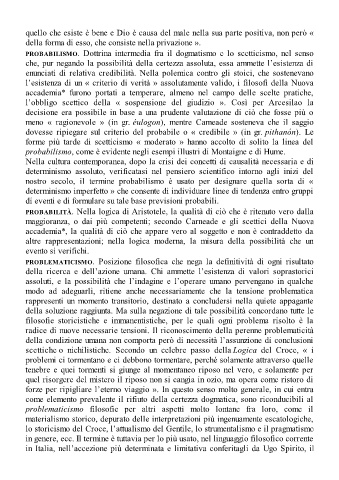Page 673 - Dizionario di Filosofia
P. 673
quello che esiste è bene e Dio è causa del male nella sua parte positiva, non però «
della forma di esso, che consiste nella privazione ».
PROBABILISMO. Dottrina intermedia fra il dogmatismo e lo scetticismo, nel senso
che, pur negando la possibilità della certezza assoluta, essa ammette l’esistenza di
enunciati di relativa credibilità. Nella polemica contro gli stoici, che sostenevano
l’esistenza di un « criterio di verità » assolutamente valido, i filosofi della Nuova
accademia* furono portati a temperare, almeno nel campo delle scelte pratiche,
l’obbligo scettico della « sospensione del giudizio ». Così per Arcesilao la
decisione era possibile in base a una prudente valutazione di ciò che fosse più o
meno « ragionevole » (in gr. éulogon), mentre Cameade sosteneva che il saggio
dovesse ripiegare sul criterio del probabile o « credibile » (in gr. pithanón). Le
forme più tarde di scetticismo « moderato » hanno accolto di solito la linea del
probabilismo, come è evidente negli esempi illustri di Montaigne e di Hume.
Nella cultura contemporanea, dopo la crisi dei concetti di causalità necessaria e di
determinismo assoluto, verificatasi nel pensiero scientifico intorno agli inizi del
nostro secolo, il termine probabilismo è usato per designare quella sorta di «
determinismo imperfetto » che consente di individuare linee di tendenza entro gruppi
di eventi e di formulare su tale base previsioni probabili.
PROBABILITÀ. Nella logica di Aristotele, la qualità di ciò che è ritenuto vero dalla
maggioranza, o dai più competenti; secondo Carneade e gli scettici della Nuova
accademia*, la qualità di ciò che appare vero al soggetto e non è contraddetto da
altre rappresentazioni; nella logica moderna, la misura della possibilità che un
evento si verifichi.
PROBLEMATICISMO. Posizione filosofica che nega la definitività di ogni risultato
della ricerca e dell’azione umana. Chi ammette l’esistenza di valori soprastorici
assoluti, e la possibilità che l’indagine e l’operare umano pervengano in qualche
modo ad adeguarli, ritiene anche necessariamente che la tensione problematica
rappresenti un momento transitorio, destinato a concludersi nella quiete appagante
della soluzione raggiunta. Ma sulla negazione di tale possibilità concordano tutte le
filosofie storicistiche e immanentistiche, per le quali ogni problema risolto è la
radice di nuove necessarie tensioni. Il riconoscimento della perenne problematicità
della condizione umana non comporta però di necessità l’assunzione di conclusioni
scettiche o nichilistiche. Secondo un celebre passo della Logica del Croce, « i
problemi ci tormentano e ci debbono tormentare, perché solamente attraverso quelle
tenebre e quei tormenti si giunge al momentaneo riposo nel vero, e solamente per
quel risorgere del mistero il riposo non si cangia in ozio, ma opera come ristoro di
forze per ripigliare l’eterno viaggio ». In questo senso molto generale, in cui entra
come elemento prevalente il rifiuto della certezza dogmatica, sono riconducibili al
problematicismo filosofie per altri aspetti molto lontane fra loro, come il
materialismo storico, depurato delle interpretazioni più ingenuamente escatologiche,
lo storicismo del Croce, l’attualismo del Gentile, lo strumentalismo e il pragmatismo
in genere, ecc. Il termine è tuttavia per lo più usato, nel linguaggio filosofico corrente
in Italia, nell’accezione più determinata e limitativa conferitagli da Ugo Spirito, il