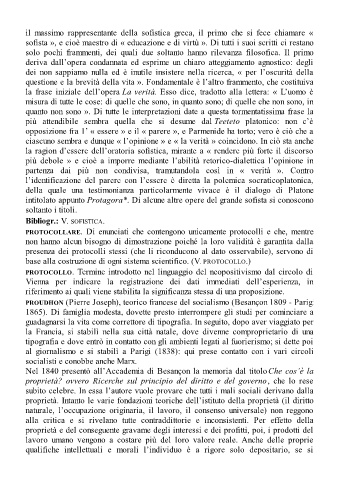Page 679 - Dizionario di Filosofia
P. 679
il massimo rappresentante della sofistica greca, il primo che si fece chiamare «
sofista », e cioè maestro di « educazione e di virtù ». Di tutti i suoi scritti ci restano
solo pochi frammenti, dei quali due soltanto hanno rilevanza filosofica. Il primo
deriva dall’opera condannata ed esprime un chiaro atteggiamento agnostico: degli
dei non sappiamo nulla ed è inutile insistere nella ricerca, « per l’oscurità della
questione e la brevità della vita ». Fondamentale è l’altro frammento, che costituiva
la frase iniziale dell’opera La verità. Esso dice, tradotto alla lettera: « L’uomo è
misura di tutte le cose: di quelle che sono, in quanto sono; di quelle che non sono, in
quanto non sono ». Di tutte le interpretazioni date a questa tormentatissima frase la
più attendibile sembra quella che si desume dal Teeteto platonico: non c’è
opposizione fra 1’ « essere » e il « parere », e Parmenide ha torto; vero è ciò che a
ciascuno sembra e dunque « l’opinione » e « la verità » coincidono. In ciò sta anche
la ragion d’essere dell’oratoria sofìstica, mirante a « rendere più forte il discorso
più debole » e cioè a imporre mediante l’abilità retorico-dialettica l’opinione in
partenza dai più non condivisa, tramutandola così in « verità ». Contro
l’identificazione del parere con l’essere è diretta la polemica socraticoplatonica,
della quale una testimonianza particolarmente vivace è il dialogo di Platone
intitolato appunto Protagora*. Di alcune altre opere del grande sofista si conoscono
soltanto i titoli.
Bibliogr.: V. SOFISTICA.
PROTOCOLLARE. Di enunciati che contengono unicamente protocolli e che, mentre
non hanno alcun bisogno di dimostrazione poiché la loro validità è garantita dalla
presenza dei protocolli stessi (che li riconducono al dato osservabile), servono di
base alla costruzione di ogni sistema scientifico. (V. PROTOCOLLO.)
PROTOCOLLO. Termine introdotto nel linguaggio del neopositivismo dal circolo di
Vienna per indicare la registrazione dei dati immediati dell’esperienza, in
riferimento ai quali viene stabilita la significanza stessa di una proposizione.
PROUDHON (Pierre Joseph), teorico francese del socialismo (Besançon 1809 - Parigi
1865). Di famiglia modesta, dovette presto interrompere gli studi per cominciare a
guadagnarsi la vita come correttore di tipografia. In seguito, dopo aver viaggiato per
la Francia, si stabilì nella sua città natale, dove divenne comproprietario di una
tipografia e dove entrò in contatto con gli ambienti legati al fuorierismo; si dette poi
al giornalismo e si stabilì a Parigi (1838): qui prese contatto con i vari circoli
socialisti e conobbe anche Marx.
Nel 1840 presentò all’Accademia di Besançon la memoria dal titolo Che cos’è la
proprietà? ovvero Ricerche sul principio del diritto e del governo, che lo rese
subito celebre. In essa l’autore vuole provare che tutti i mali sociali derivano dalla
proprietà. Intanto le varie fondazioni teoriche dell’istituto della proprietà (il diritto
naturale, l’occupazione originaria, il lavoro, il consenso universale) non reggono
alla critica e si rivelano tutte contraddittorie e inconsistenti. Per effetto della
proprietà e del conseguente gravame degli interessi e dei profitti, poi, i prodotti del
lavoro umano vengono a costare più del loro valore reale. Anche delle proprie
qualifiche intellettuali e morali l’individuo è a rigore solo depositario, se si