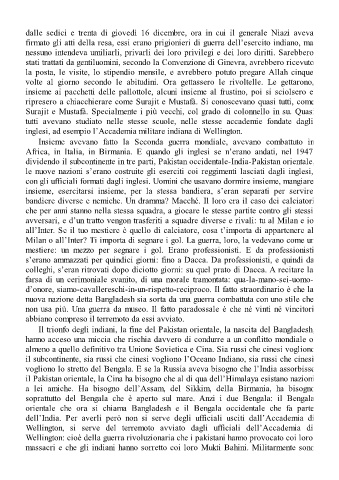Page 85 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 85
dalle sedici e trenta di giovedì 16 dicembre, ora in cui il generale Niazi aveva
firmato gli atti della resa, essi erano prigionieri di guerra dell’esercito indiano, ma
nessuno intendeva umiliarli, privarli dei loro privilegi e dei loro diritti. Sarebbero
stati trattati da gentiluomini, secondo la Convenzione di Ginevra, avrebbero ricevuto
la posta, le visite, lo stipendio mensile, e avrebbero potuto pregare Allah cinque
volte al giorno secondo le abitudini. Ora gettassero le rivoltelle. Le gettarono,
insieme ai pacchetti delle pallottole, alcuni insieme al frustino, poi si sciolsero e
ripresero a chiacchierare come Surajit e Mustafà. Si conoscevano quasi tutti, come
Surajit e Mustafà. Specialmente i più vecchi, col grado di colonnello in su. Quasi
tutti avevano studiato nelle stesse scuole, nelle stesse accademie fondate dagli
inglesi, ad esempio l’Accademia militare indiana di Wellington.
Insieme avevano fatto la Seconda guerra mondiale, avevano combattuto in
Africa, in Italia, in Birmania. E quando gli inglesi se n’erano andati, nel 1947,
dividendo il subcontinente in tre parti, Pakistan occidentale-India-Pakistan orientale,
le nuove nazioni s’erano costruite gli eserciti coi reggimenti lasciati dagli inglesi,
con gli ufficiali formati dagli inglesi. Uomini che usavano dormire insieme, mangiare
insieme, esercitarsi insieme, per la stessa bandiera, s’eran separati per servire
bandiere diverse e nemiche. Un dramma? Macché. Il loro era il caso dei calciatori
che per anni stanno nella stessa squadra, a giocare le stesse partite contro gli stessi
avversari, e d’un tratto vengon trasferiti a squadre diverse e rivali: tu al Milan e io
all’Inter. Se il tuo mestiere è quello di calciatore, cosa t’importa di appartenere al
Milan o all’Inter? Ti importa di segnare i gol. La guerra, loro, la vedevano come un
mestiere: un mezzo per segnare i gol. Erano professionisti. E da professionisti
s’erano ammazzati per quindici giorni: fino a Dacca. Da professionisti, e quindi da
colleghi, s’eran ritrovati dopo diciotto giorni: su quel prato di Dacca. A recitare la
farsa di un cerimoniale svanito, di una morale tramontata: qua-la-mano-sei-uomo-
d’onore, siamo-cavallereschi-in-un-rispetto-reciproco. Il fatto straordinario è che la
nuova nazione detta Bangladesh sia sorta da una guerra combattuta con uno stile che
non usa più. Una guerra da museo. Il fatto paradossale è che né vinti né vincitori
abbiano compreso il terremoto da essi avviato.
Il trionfo degli indiani, la fine del Pakistan orientale, la nascita del Bangladesh,
hanno acceso una miccia che rischia davvero di condurre a un conflitto mondiale o
almeno a quello definitivo tra Unione Sovietica e Cina. Sia russi che cinesi vogliono
il subcontinente, sia russi che cinesi vogliono l’Oceano Indiano, sia russi che cinesi
vogliono lo stretto del Bengala. E se la Russia aveva bisogno che l’India assorbisse
il Pakistan orientale, la Cina ha bisogno che al di qua dell’Himalaya esistano nazioni
a lei amiche. Ha bisogno dell’Assam, del Sikkim, della Birmania, ha bisogno
soprattutto del Bengala che è aperto sul mare. Anzi i due Bengala: il Bengala
orientale che ora si chiama Bangladesh e il Bengala occidentale che fa parte
dell’India. Per averli però non si serve degli ufficiali usciti dall’Accademia di
Wellington, si serve del terremoto avviato dagli ufficiali dell’Accademia di
Wellington: cioè della guerra rivoluzionaria che i pakistani hanno provocato coi loro
massacri e che gli indiani hanno sorretto coi loro Mukti Bahini. Militarmente sono