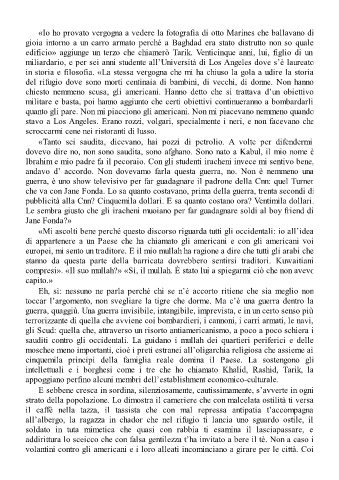Page 109 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 109
«Io ho provato vergogna a vedere la fotografia di otto Marines che ballavano di
gioia intorno a un carro armato perché a Baghdad era stato distrutto non so quale
edificio» aggiunge un terzo che chiamerò Tarik. Venticinque anni, lui, figlio di un
miliardario, e per sei anni studente all’Università di Los Angeles dove s’è laureato
in storia e filosofia. «La stessa vergogna che mi ha chiuso la gola a udire la storia
del rifugio dove sono morti centinaia di bambini, di vecchi, di donne. Non hanno
chiesto nemmeno scusa, gli americani. Hanno detto che si trattava d’un obiettivo
militare e basta, poi hanno aggiunto che certi obiettivi continueranno a bombardarli
quanto gli pare. Non mi piacciono gli americani. Non mi piacevano nemmeno quando
stavo a Los Angeles. Erano rozzi, volgari, specialmente i neri, e non facevano che
scroccarmi cene nei ristoranti di lusso.
«Tanto sei saudita, dicevano, hai pozzi di petrolio. A volte per difendermi
dovevo dire no, non sono saudita, sono afghano. Sono nato a Kabul, il mio nome è
Ibrahim e mio padre fa il pecoraio. Con gli studenti iracheni invece mi sentivo bene,
andavo d’ accordo. Non dovevamo farla questa guerra, no. Non è nemmeno una
guerra, è uno show televisivo per far guadagnare il padrone della Cnn: quel Turner
che va con Jane Fonda. Lo sa quanto costavano, prima della guerra, trenta secondi di
pubblicità alla Cnn? Cinquemila dollari. E sa quanto costano ora? Ventimila dollari.
Le sembra giusto che gli iracheni muoiano per far guadagnare soldi al boy friend di
Jane Fonda?»
«Mi ascolti bene perché questo discorso riguarda tutti gli occidentali: io all’idea
di appartenere a un Paese che ha chiamato gli americani e con gli americani voi
europei, mi sento un traditore. E il mio mullah ha ragione a dire che tutti gli arabi che
stanno da questa parte della barricata dovrebbero sentirsi traditori. Kuwaitiani
compresi». «Il suo mullah?» «Sì, il mullah. È stato lui a spiegarmi ciò che non avevo
capito.»
Eh, sì: nessuno ne parla perché chi se n’è accorto ritiene che sia meglio non
toccar l’argomento, non svegliare la tigre che dorme. Ma c’è una guerra dentro la
guerra, quaggiù. Una guerra invisibile, intangibile, imprevista, e in un certo senso più
terrorizzante di quella che avviene coi bombardieri, i cannoni, i carri armati, le navi,
gli Scud: quella che, attraverso un risorto antiamericanismo, a poco a poco schiera i
sauditi contro gli occidentali. La guidano i mullah dei quartieri periferici e delle
moschee meno importanti, cioè i preti estranei all’oligarchia religiosa che assieme ai
cinquemila principi della famiglia reale domina il Paese. La sostengono gli
intellettuali e i borghesi come i tre che ho chiamato Khalid, Rashid, Tarik, la
appoggiano perfino alcuni membri dell’establishment economico-culturale.
E sebbene cresca in sordina, silenziosamente, cautissimamente, s’avverte in ogni
strato della popolazione. Lo dimostra il cameriere che con malcelata ostilità ti versa
il caffè nella tazza, il tassista che con mal repressa antipatia t’accompagna
all’albergo, la ragazza in chador che nel rifugio ti lancia uno sguardo ostile, il
soldato in tuta mimetica che quasi con rabbia ti esamina il lasciapassare, e
addirittura lo sceicco che con falsa gentilezza t’ha invitato a bere il tè. Non a caso i
volantini contro gli americani e i loro alleati incominciano a girare per le città. Coi