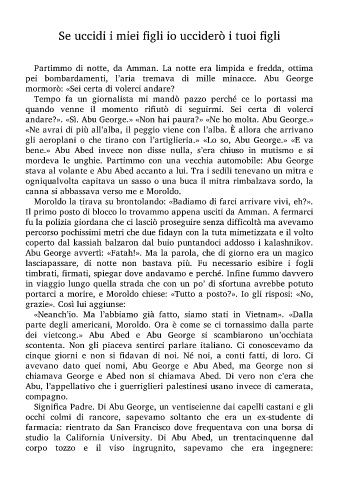Page 51 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 51
Se uccidi i miei figli io ucciderò i tuoi figli
Partimmo di notte, da Amman. La notte era limpida e fredda, ottima
pei bombardamenti, l’aria tremava di mille minacce. Abu George
mormorò: «Sei certa di volerci andare?
Tempo fa un giornalista mi mandò pazzo perché ce lo portassi ma
quando venne il momento ri utò di seguirmi. Sei certa di volerci
andare?». «Sì. Abu George.» «Non hai paura?» «Ne ho molta. Abu George.»
«Ne avrai di più all’alba, il peggio viene con l’alba. È allora che arrivano
gli aeroplani o che tirano con l’artiglieria.» «Lo so, Abu George.» «E va
bene.» Abu Abed invece non disse nulla, s’era chiuso in mutismo e si
mordeva le unghie. Partimmo con una vecchia automobile: Abu George
stava al volante e Abu Abed accanto a lui. Tra i sedili tenevano un mitra e
ogniqualvolta capitava un sasso o una buca il mitra rimbalzava sordo, la
canna si abbassava verso me e Moroldo.
Moroldo la tirava su brontolando: «Badiamo di farci arrivare vivi, eh?».
Il primo posto di blocco lo trovammo appena usciti da Amman. A fermarci
fu la polizia giordana che ci lasciò proseguire senza difficoltà ma avevamo
percorso pochissimi metri che due fidayn con la tuta mimetizzata e il volto
coperto dal kassiah balzaron dal buio puntandoci addosso i kalashnikov.
Abu George avvertì: «Fatah!». Ma la parola, che di giorno era un magico
lasciapassare, di notte non bastava più. Fu necessario esibire i fogli
timbrati, rmati, spiegar dove andavamo e perché. In ne fummo davvero
in viaggio lungo quella strada che con un po’ di sfortuna avrebbe potuto
portarci a morire, e Moroldo chiese: «Tutto a posto?». Io gli risposi: «No,
grazie». Così lui aggiunse:
«Neanch’io. Ma l’abbiamo già fatto, siamo stati in Vietnam». «Dalla
parte degli americani, Moroldo. Ora è come se ci tornassimo dalla parte
dei vietcong.» Abu Abed e Abu George si scambiarono un’occhiata
scontenta. Non gli piaceva sentirci parlare italiano. Ci conoscevamo da
cinque giorni e non si davan di noi. Né noi, a conti fatti, di loro. Ci
avevano dato quei nomi, Abu George e Abu Abed, ma George non si
chiamava George e Abed non si chiamava Abed. Di vero non c’era che
Abu, l’appellativo che i guerriglieri palestinesi usano invece di camerata,
compagno.
Signi ca Padre. Di Abu George, un ventiseienne dai capelli castani e gli
occhi colmi di rancore, sapevamo soltanto che era un ex-studente di
farmacia: rientrato da San Francisco dove frequentava con una borsa di
studio la California University. Di Abu Abed, un trentacinquenne dal
corpo tozzo e il viso ingrugnito, sapevamo che era ingegnere: