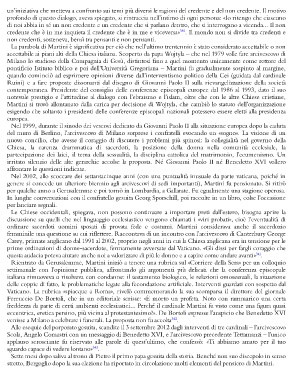Page 99 - Francesco tra i lupi
P. 99
un’iniziativa che metteva a confronto sui temi più diversi le ragioni del credente e del non credente. Il motivo
profondo di questo dialogo, aveva spiegato, si rintraccia nell’intimo di ogni persona: «Io ritengo che ciascuno
di noi abbia in sé un non credente e un credente che si parlano dentro, che si interrogano a vicenda... Il non
340
credente che è in me inquieta il credente che è in me e viceversa» . Il mondo non si divide tra credenti e
non credenti, sosteneva, bensì tra pensanti e non pensanti.
La parabola di Martini è significativa per ciò che nell’ultimo trentennio è stato considerato accettabile o non
accettabile ai piani alti della Chiesa italiana. Scoperto da papa Wojtyla – che nel 1979 volle fare arcivescovo di
Milano lo studioso della Compagnia di Gesù, distintosi fino a quel momento unicamente come rettore del
pontificio Istituto biblico e poi dell’Università Gregoriana – Martini fu gradualmente sospinto al margine,
quando cominciò ad esprimere opinioni diverse dall’interventismo politico della Cei (guidata dal cardinale
Ruini) e a fare proposte dissonanti dal disegno di Giovanni Paolo II sulla rievangelizzazione della società
contemporanea. Presidente del consiglio delle conferenze episcopali europee dal 1986 al 1993, dato il suo
notevole prestigio e l’attitudine al dialogo con l’ebraismo e l’islam, oltre che con le altre Chiese cristiane,
Martini si trovò allontanato dalla carica per decisione di Wojtyla, che cambiò lo statuto dell’organizzazione
esigendo che soltanto i presidenti delle conferenze episcopali nazionali potessero essere eletti alla presidenza
europea.
Nel 1999, durante il sinodo dei vescovi dedicato da Giovanni Paolo II alla situazione europea dopo la caduta
del muro di Berlino, l’arcivescovo di Milano sorprese i confratelli evocando un «sogno». La visione di un
nuovo concilio, che avesse il coraggio di discutere i problemi più spinosi: la collegialità nel governo della
Chiesa, la carenza drammatica di sacerdoti, la posizione della donna nella comunità ecclesiale, la
partecipazione dei laici, il tema della sessualità, la disciplina cattolica del matrimonio, l’ecumenismo. Un
irritato silenzio delle alte gerarchie accolse la proposta. Né Giovanni Paolo II né Benedetto XVI vollero
affrontare le questioni indicate.
Nel 2002, allo scoccare dei settantacinque anni (con una puntualità inusuale da parte vaticana, poiché in
genere si concede un ulteriore biennio agli arcivescovi di sedi importanti), Martini fu pensionato. Si ritirò
per qualche anno a Gerusalemme e poi tornò in Lombardia, a Gallarate. Fu egualmente una stagione operosa.
In lunghe conversazioni con il confratello gesuita Georg Sporschill, poi raccolte in un libro, colse l’occasione
per lanciare segnali.
Le Chiese occidentali, spiegava, non possono continuare a importare preti dall’estero, bisogna aprire la
discussione su quelli che nel linguaggio ecclesiastico vengono chiamati i «viri probati», cioè l’eventualità di
ordinare sacerdoti uomini sposati di provata fede e costumi. Martini considerava anche il sacerdozio
femminile una questione su cui riflettere. Raccontava di un incontro con l’arcivescovo di Canterbury George
Carey, primate anglicano dal 1991 al 2002, proprio negli anni in cui la Chiesa anglicana era in tensione per le
prime ordinazioni di donne-sacerdote, fermamente avversate dal Vaticano. «Gli dissi per fargli coraggio che
341
questa audacia poteva aiutare anche noi a valorizzare di più le donne e a capire come andare avanti» .
Rientrato da Gerusalemme, Martini iniziò a tenere una rubrica sul «Corriere della Sera» per un colloquio
settimanale con l’opinione pubblica, affrontando gli argomenti più delicati che la conferenza episcopale
italiana rimuoveva o risolveva con condanne: il testamento biologico, le relazioni omosessuali, la situazione
delle coppie di fatto, le problematiche legate alla fecondazione artificiale. Interventi guardati con sospetto dal
Vaticano. La rubrica «spiacque a Roma», rivelò commemorando la sua scomparsa il direttore del giornale
Ferruccio De Bortoli, che in un editoriale scrisse: «È morto un profeta. Noto con rammarico una certa
freddezza da parte di certi ambienti ecclesiastici... Perché il cardinale Martini fu visto come una figura quasi
eccentrica, eretica persino, più vicina al protestantesimo?». De Bortoli espresse l’auspicio che Benedetto XVI
342
venisse a Milano a celebrare i funerali. La proposta non fu accolta .
Alle esequie del porporato gesuita, scandite il 3 settembre 2012 dagli interventi di tre cardinali – l’arcivescovo
Scola, Angelo Comastri con un messaggio di Benedetto XVI, e l’arcivescovo precedente Tettamanzi – l’unico
applauso scrosciante fu riservato alle parole di quest’ultimo, che confessò: «Ti abbiamo amato per il tuo
343
sguardo capace di vedere lontano» .
Sette mesi dopo saliva al trono di Pietro il primo papa gesuita della storia. Benché non suo discepolo in senso
stretto, Bergoglio dopo la sua elezione ha riportato in circolazione molti elementi del pensiero di Martini.