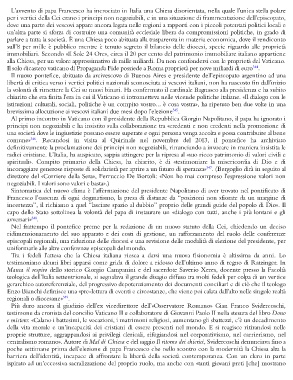Page 100 - Francesco tra i lupi
P. 100
L’avvento di papa Francesco ha incrociato in Italia una Chiesa disorientata, nella quale l’unica stella polare
per i vertici della Cei erano i principi non negoziabili, e in una situazione di frammentazione dell’episcopato,
dove una parte dei vescovi appare ancora legata nelle regioni a rapporti con i piccoli potentati politici locali e
un’altra parte si sforza di costruire una comunità ecclesiale libera da compromissioni politiche, in grado di
parlare a tutta la società. È una Chiesa poco abituata alla trasparenza in materia economica, dove il rendiconto
sull’8 per mille è pubblico mentre è tenuto segreto il bilancio delle diocesi, specie riguardo alle proprietà
immobiliari. Secondo «Il Sole 24 Ore», circa il 20 per cento del patrimonio immobiliare italiano appartiene
alla Chiesa, per un valore approssimativo di mille miliardi. Da non confondersi con le proprietà del Vaticano.
344
Il solo dicastero vaticano di Propaganda Fide possiede a Roma proprietà per nove miliardi di euro .
Il nuovo pontefice, abituato da arcivescovo di Buenos Aires e presidente dell’episcopato argentino ad una
libertà di critica verso i vertici politici nazionali sconosciuta ai vescovi italiani, non ha nascosto fin dall’inizio
la volontà di rimettere la Cei su nuovi binari. Ha confermato il cardinale Bagnasco alla presidenza e ha subito
chiarito che era finita l’era in cui il Vaticano si intrometteva nelle vicende politiche italiane. «Il dialogo con le
istituzioni culturali, sociali, politiche è un compito vostro... è cosa vostra», ha ripetuto ben due volte in una
345
brevissima allocuzione ai vescovi italiani due mesi dopo l’elezione .
Al primo incontro in Vaticano con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il papa ha ignorato i
principi non negoziabili e ha insistito sulla collaborazione tra «credenti e non credenti nella promozione di
una società dove le ingiustizie possano essere superate e ogni persona venga accolta e possa contribuire al bene
346
comune» . Recandosi in visita al Quirinale nel novembre del 2013, il pontefice ha archiviato
definitivamente la proclamazione dei principi non negoziabili, rinunciando a invocare in maniera insistita le
radici cristiane. L’Italia, ha auspicato, sappia attingere per la ripresa al «suo ricco patrimonio di valori civili e
spirituali». Compito primario della Chiesa, ha chiarito, è di «testimoniare la misericordia di Dio e di
347
incoraggiare generose risposte di solidarietà per aprire a un futuro di speranza» . (Bergoglio dirà in seguito al
direttore del «Corriere della Sera», Ferruccio De Bortoli: «Non ho mai compreso l’espressione valori non
negoziabili. I valori sono valori e basta».)
Sintomatica del nuovo clima è l’affermazione del presidente Napolitano di aver trovato nel pontificato di
Francesco l’«assenza di ogni dogmatismo, la presa di distanze da “posizioni non sfiorate da un margine di
incertezza”, il richiamo a quel “lasciare spazio al dubbio” proprio delle grandi guide del popolo di Dio». Il
capo dello Stato sottolinea la volontà del papa di instaurare un «dialogo con tutti, anche i più lontani e gli
348
avversari» .
Nel frattempo il pontefice preme per la redazione di un nuovo statuto della Cei, chiedendo un deciso
ridimensionamento del suo apparato e dei costi di gestione, un rafforzamento del ruolo delle conferenze
episcopali regionali, una riduzione delle diocesi e una revisione delle modalità di elezione del presidente, per
uniformarle alle altre conferenze episcopali del mondo.
Tra i fedeli l’attesa che la Chiesa italiana riesca a darsi una nuova fisionomia è altissima da anni. Lo
testimoniano alcuni libri apparsi come grida di dolore a ridosso dell’ultimo anno di regno di Ratzinger. In
Manca il respiro dello storico Giorgio Campanini e del sacerdote Saverio Xeres, docente presso la Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale, si segnalava il grande disagio diffuso tra molti fedeli per colpa di un vertice
gerarchico autoreferenziale, del progressivo depotenziamento dei documenti conciliari e di ciò che il teologo
Enzo Bianchi definisce una «pre-lettura di eventi e circostanze, che viene poi calata dall’alto nelle singole realtà
349
regionali o diocesane» .
Più duro ancora il giudizio dell’ex vicedirettore dell’«Osservatore Romano» Gian Franco Svidercoschi,
testimone da cronista del concilio Vaticano II e collaboratore di Giovanni Paolo II nella stesura del libro Dono
e mistero: «Calano i battesimi, le vocazioni, i matrimoni religiosi, aumentano gli sbattezzi, c’è un decadimento
della vita morale e un’incapacità dei cristiani di essere presenti nel mondo. E si reagisce ritirandosi nelle
proprie strutture, aggrappandosi ai privilegi clericali, rifugiandosi nel corporativismo, nel carrierismo, nel
centralismo romano». Autore di Mal di Chiesa e del saggio Il ritorno dei chierici, Svidercoschi denunciava fino a
poche settimane prima dell’elezione di papa Francesco che nello scontro con la modernità la Chiesa alza la
barriera dell’identità, incapace di affrontare la libertà della società contemporanea. Con un clero in parte
ispirato ad un’eccessiva sacralizzazione del proprio ruolo, ma anche con «tanti giovani preti [che] mostrano