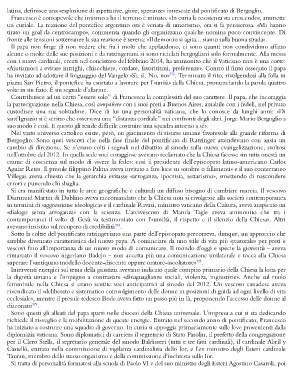Page 108 - Francesco tra i lupi
P. 108
latina, definisce una «esplosione di aspettative, gioie, speranze» innescate dal pontificato di Bergoglio.
Francesco è consapevole che intorno a lui il terreno è minato. «In curia la resistenza sta crescendo», ammette
un curiale. La reazione del pontefice argentino ora è venata di umorismo, ora si fa pensierosa. «Mi hanno
tirato un goal da centrocampo», commenta quando gli organizzano qualche nomina poco convincente. Di
fronte alle tensioni sotterranee la sua reazione è serena: «Il demonio si agita... siamo sulla buona strada».
Il papa non finge di non vedere che fra i molti che applaudono, ci sono quanti non condividono affatto
alcune o molte delle sue posizioni e da ratzingeriani si sono riciclati bergogliani solo formalmente. Alla messa
con i nuovi cardinali, creati nel concistoro del febbraio 2014, ha ammonito che il Vaticano non è una corte:
«Aiutiamoci a evitare intrighi, chiacchiere, cordate, favoritismi, preferenze». Contro il finto ossequio il papa
372
ha invitato ad adottare il linguaggio del Vangelo «Sì, sì. No, no» . Terminato il rito, rivolgendosi alla folla in
piazza San Pietro, il pontefice ha esortato a lavorare per l’«unità» della Chiesa, pronunciando la parola quattro
volte in un fiato. È un segnale d’allarme.
Contribuisce ad un certo “essere solo” di Francesco la complessità del suo carattere. Il papa, che incoraggia
la partecipazione nella Chiesa, così compañero con i suoi preti a Buenos Aires, amabile con i fedeli, nel privato
custodisce una sua solitudine. Dice di lui una personalità vaticana, che lo conosce da lunghi anni: «Di
sant’Ignazio si è scritto che osservava una “distanza cordiale” nei confronti degli altri. Jorge Mario Bergoglio a
suo modo è così. E questo gli rende difficile costruire una squadra intorno a sé».
Nel vasto universo cattolico esiste, però, un giacimento di risorse umane favorevole alla grande riforma di
Bergoglio. Sono quei vescovi che nella fase finale del pontificato di Ratzinger attendevano con ansia un
cambio di direzione. Se n’erano colti i segnali nel dibattito al sinodo sulla nuova evangelizzazione, svoltosi
nell’ottobre del 2012. In quella sede voci coraggiose avevano reclamato che la Chiesa facesse «in tutta onestà un
esame di coscienza sul modo di vivere la fede»: così il presidente dell’episcopato latino-americano Carlos
Aguiar Retes. Il presule filippino Palma aveva invitato a fare luce su «ombre o fallimenti» e il suo conterraneo
Villegas aveva chiesto che la gerarchia evitasse «arroganza, ipocrisia, settarismo», smettendo di nascondere
errori e punendo chi sbaglia.
Si era manifestato in tutte le aree geografiche e culturali un diffuso bisogno di cambiare marcia. Il vescovo
Diarmuid Martin di Dublino aveva raccomandato che la Chiesa non si rivolgesse alla società contemporanea
in termini di «aggressione ideologica» e il cardinale Ravasi, ministro vaticano della Cultura, aveva auspicato un
«dialogo senza arroganza» con la scienza. L’arcivescovo di Manila Tagle aveva ammonito che tra i
contemporanei il volto di Gesù va testimoniato con l’«umiltà, il rispetto e il silenzio della Chiesa». Altri
373
avevano insistito sul recupero di credibilità .
Sotto la coltre del pontificato ratzingeriano una parte dell’episcopato precorreva, dunque, un approccio che
sarebbe diventato caratteristica del nuovo papa. A cominciare da uno stile di vita più «pastorale» per preti e
vescovi fino all’importanza di un nuovo modo di comunicare. Il mondo d’oggi e specie la gioventù – aveva
rimarcato il vescovo nigeriano Badejo – non accetta più una comunicazione unilaterale e tocca alla Chiesa
374
superare l’«antiquato modello docente-discente oppure oratore-ascoltatore» .
Interventi energici sul tema della giustizia avevano indicato quale compito primario della Chiesa la lotta per
la dignità umana e l’impegno a contrastare «disuguaglianze sociali, violenza, ingiustizie». Anche sul ruolo
femminile nella Chiesa si erano sentite voci anticipatrici al sinodo del 2012. Un vescovo canadese aveva
rivendicato il «deliberato e sistematico coinvolgimento delle donne in posizioni di guida ad ogni livello di vita
ecclesiale», mentre il presule tedesco Bode aveva fatto un passo più in là, proponendo l’accesso delle donne al
375
diaconato .
Sono questi gli alleati del papa sparsi nelle diocesi della Chiesa universale. L’impresa a cui si sta dedicando
richiede il risveglio e la mobilitazione di queste energie. Entrato nel secondo anno di pontificato, Francesco
ha iniziato a costruire una squadra di governo. In curia si appoggia primariamente sulle leve provenienti dalla
diplomazia vaticana. Sono diplomatici di carriera il segretario di Stato Parolin, il prefetto della congregazione
per il Clero Stella, il segretario generale del sinodo Baldisseri (tutti e tre fatti cardinali), il cardinale Abril y
Castelló, entrato nella commissione di vigilanza cardinalizia dello Ior, e l’ex ministro degli Esteri cardinale
Tauran, membro dello stesso organismo e della commissione d’inchiesta sullo Ior.
Si tratta di personalità formatesi alla scuola di Paolo VI e del suo ministro degli Esteri Agostino Casaroli, poi