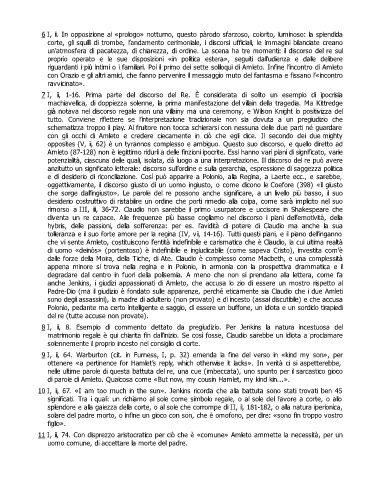Page 377 - Shakespeare - Vol. 3
P. 377
6 I, ii. In opposizione al «prologo» notturno, questo pàrodo sfarzoso, colorito, luminoso: la splendida
corte, gli squilli di trombe, l’andamento cerimoniale, i discorsi ufficiali, le immagini bilanciate creano
un’atmosfera di pacatezza, di chiarezza, di ordine. La scena ha tre momenti: il discorso del re sul
proprio operato e le sue disposizioni «in politica estera», seguiti dall’udienza e dalle delibere
riguardanti i più intimi o i familiari. Poi il primo dei sette soliloqui di Amleto. Infine l’incontro di Amleto
con Orazio e gli altri amici, che fanno pervenire il messaggio muto del fantasma e fissano l’«incontro
ravvicinato».
7 I, ii, 1-16. Prima parte del discorso del Re. È considerata di solito un esempio di ipocrisia
machiavellica, di doppiezza solenne, la prima manifestazione del villain della tragedia. Ma Kittredge
già notava nel discorso regale non una villainy ma una ceremony, e Wilson Knight lo positivizza del
tutto. Conviene riflettere se l’interpretazione tradizionale non sia dovuta a un pregiudizio che
schematizza troppo il play. Al fruitore non tocca schierarsi con nessuna delle due parti né guardare
con gli occhi di Amleto e credere ciecamente in ciò che egli dice. Il secondo dei due mighty
opposites (V, ii, 62) è un tyrannos complesso e ambiguo. Questo suo discorso, e quello diretto ad
Amleto (87-128) non è legittimo ridurli a delle finzioni ipocrite. Essi hanno vari piani di significato, varie
potenzialità, ciascuna delle quali, isolata, dà luogo a una interpretazione. Il discorso del re può avere
anzitutto un significato letterale: discorso sull’ordine e sulla gerarchia, espressione di saggezza politica
e di desiderio di riconciliazione. Così può apparire a Polonio, alla Regina, a Laerte ecc., e sarebbe,
oggettivamente, il discorso giusto di un uomo ingiusto, o come dicono le Coefore (398) «il giusto
che sorge dall’ingiusto». Le parole del re possono anche significare, a un livello più basso, il suo
desiderio costruttivo di ristabilire un ordine che porti rimedio alla colpa, come sarà implicito nel suo
rimorso a III, iii, 36-72. Claudio non sarebbe il primo usurpatore e uccisore in Shakespeare che
diventa un re capace. Alle frequenze più basse cogliamo nel discorso i piani dell’emotività, della
hybris, delle passioni, della sofferenza: per es. l’avidità di potere di Claudio ma anche la sua
tolleranza e il suo forte amore per la regina (IV, vii, 14-16). Tutti questi piani, e il piano dell’inganno
che vi sente Amleto, costituiscono l’entità indefinibile e carismatica che è Claudio, la cui ultima realtà
di uomo «deinòs» (portentoso) è indefinibile e ingiudicabile (come sapeva Cristo), investita com’è
dalle forze della Moira, della Tiche, di Ate. Claudio è complesso come Macbeth, e una complessità
appena minore si trova nella regina e in Polonio, in armonia con la prospettiva drammatica e il
degradare dal centro in fuori della polisemia. A meno che non si prendano alla lettera, come fa
anche Jenkins, i giudizi appassionati di Amleto, che accusa lo zio di essere un mostro rispetto al
Padre-Dio (ma il giudizio è fondato sulle apparenze, perché eticamente sia Claudio che i due Amleti
sono degli assassini), la madre di adulterio (non provato) e di incesto (assai discutibile) e che accusa
Polonio, pedante ma certo intelligente e saggio, di essere un buffone, un idiota e un sordido tirapiedi
del re (tutte accuse non provate).
8 I, ii, 8. Esempio di commento dettato da pregiudizio. Per Jenkins la natura incestuosa del
matrimonio regale è qui chiarita fin dall’inizio. Se così fosse, Claudio sarebbe un idiota a proclamare
solennemente il proprio incesto nel consiglio di corte.
9 I, ii, 64. Warburton (cit. in Furness, I, p. 32) emenda la fine del verso in «kind my son», per
ottenere «a pertinence for Hamlet’s reply, which otherwise it lacks». In verità ci si aspetterebbe,
nelle ultime parole di questa battuta del re, una cue (imbeccata), uno spunto per il sarcastico gioco
di parole di Amleto. Qualcosa come «But now, my cousin Hamlet, my kind kin...».
10 I, ii, 67. «I am too much in the sun». Jenkins ricorda che alla battuta sono stati trovati ben 45
significati. Tra i quali: un richiamo al sole come simbolo regale, o al sole del favore a corte, o allo
splendore e alla gaiezza della corte, o al sole che corrompe di II, ii, 181-182, o alla natura iperionica,
solare del padre morto, o infine un gioco con son, che è omofono, per dire: «sono fin troppo vostro
figlio».
11 I, ii, 74. Con disprezzo aristocratico per ciò che è «comune» Amleto ammette la necessità, per un
uomo comune, di accettare la morte del padre.