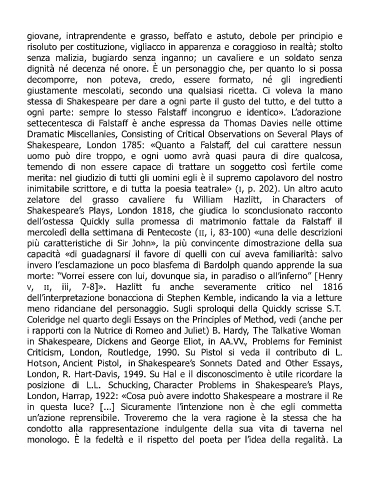Page 842 - Shakespeare - Vol. 2
P. 842
giovane, intraprendente e grasso, beffato e astuto, debole per principio e
risoluto per costituzione, vigliacco in apparenza e coraggioso in realtà; stolto
senza malizia, bugiardo senza inganno; un cavaliere e un soldato senza
dignità né decenza né onore. È un personaggio che, per quanto lo si possa
decomporre, non poteva, credo, essere formato, né gli ingredienti
giustamente mescolati, secondo una qualsiasi ricetta. Ci voleva la mano
stessa di Shakespeare per dare a ogni parte il gusto del tutto, e del tutto a
ogni parte: sempre lo stesso Falstaff incongruo e identico». L’adorazione
settecentesca di Falstaff è anche espressa da Thomas Davies nelle ottime
Dramatic Miscellanies, Consisting of Critical Observations on Several Plays of
Shakespeare, London 1785: «Quanto a Falstaff, del cui carattere nessun
uomo può dire troppo, e ogni uomo avrà quasi paura di dire qualcosa,
temendo di non essere capace di trattare un soggetto così fertile come
merita: nel giudizio di tutti gli uomini egli è il supremo capolavoro del nostro
inimitabile scrittore, e di tutta la poesia teatrale» (I, p. 202). Un altro acuto
zelatore del grasso cavaliere fu William Hazlitt, in Characters of
Shakespeare’s Plays, London 1818, che giudica lo sconclusionato racconto
dell’ostessa Quickly sulla promessa di matrimonio fattale da Falstaff il
mercoledì della settimana di Pentecoste (II, i, 83-100) «una delle descrizioni
più caratteristiche di Sir John», la più convincente dimostrazione della sua
capacità «di guadagnarsi il favore di quelli con cui aveva familiarità: salvo
invero l’esclamazione un poco blasfema di Bardolph quando apprende la sua
morte: “Vorrei essere con lui, dovunque sia, in paradiso o all’inferno” [Henry
V, II, iii, 7-8]». Hazlitt fu anche severamente critico nel 1816
dell’interpretazione bonacciona di Stephen Kemble, indicando la via a letture
meno ridanciane del personaggio. Sugli sproloqui della Quickly scrisse S.T.
Coleridge nel quarto degli Essays on the Principles of Method, vedi (anche per
i rapporti con la Nutrice di Romeo and Juliet) B. Hardy, The Talkative Woman
in Shakespeare, Dickens and George Eliot, in AA.VV., Problems for Feminist
Criticism, London, Routledge, 1990. Su Pistol si veda il contributo di L.
Hotson, Ancient Pistol, in Shakespeare’s Sonnets Dated and Other Essays,
London, R. Hart-Davis, 1949. Su Hal e il disconoscimento è utile ricordare la
posizione di L.L. Schucking, Character Problems in Shakespeare’s Plays,
London, Harrap, 1922: «Cosa può avere indotto Shakespeare a mostrare il Re
in questa luce? [...] Sicuramente l’intenzione non è che egli commetta
un’azione reprensibile. Troveremo che la vera ragione è la stessa che ha
condotto alla rappresentazione indulgente della sua vita di taverna nel
monologo. È la fedeltà e il rispetto del poeta per l’idea della regalità. La