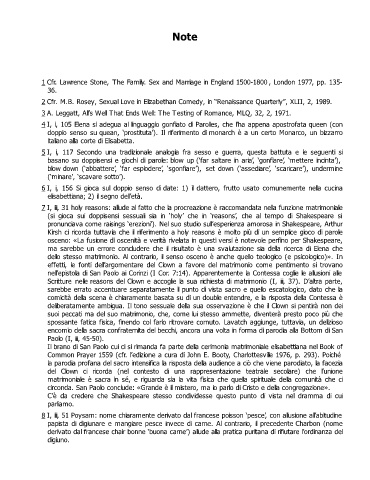Page 914 - Shakespeare - Vol. 3
P. 914
Note
1 Cfr. Lawrence Stone, The Family. Sex and Marriage in England 1500-1800 , London 1977, pp. 135-
36.
2 Cfr. M.B. Rosey, Sexual Love in Elizabethan Comedy, in “Renaissance Quarterly”, XLII, 2, 1989.
3 A. Leggatt, All’s Well That Ends Well: The Testing of Romance, MLQ, 32, 2, 1971.
4 I, i, 105 Elena si adegua al linguaggio gonfiato di Parolles, che l’ha appena apostrofata queen (con
doppio senso su quean, ‘prostituta’). Il riferimento di monarch è a un certo Monarco, un bizzarro
italiano alla corte di Elisabetta.
5 I, i, 117 Secondo una tradizionale analogia fra sesso e guerra, questa battuta e le seguenti si
basano su doppisensi e giochi di parole: blow up (‘far saltare in aria’, ‘gonfiare’, ‘mettere incinta’),
blow down (‘abbattere’, ‘far esplodere’, ‘sgonfiare’), set down (‘assediare’, ‘scaricare’), undermine
(‘minare’, ‘scavare sotto’).
6 I, i, 156 Si gioca sul doppio senso di date: 1) il dattero, frutto usato comunemente nella cucina
elisabettiana; 2) il segno dell’età.
7 I, iii, 31 holy reasons: allude al fatto che la procreazione è raccomandata nella funzione matrimoniale
(si gioca sui doppisensi sessuali sia in ‘holy’ che in ‘reasons’, che al tempo di Shakespeare si
pronunciava come raisings ‘erezioni’). Nel suo studio sull’esperienza amorosa in Shakespeare, Arthur
Kirsh ci ricorda tuttavia che il riferimento a holy reasons è molto più di un semplice gioco di parole
osceno: «La fusione di oscenità e verità rivelata in questi versi è notevole perfino per Shakespeare,
ma sarebbe un errore concludere che il risultato è una svalutazione sia della ricerca di Elena che
dello stesso matrimonio. Al contrario, il senso osceno è anche quello teologico (e psicologico)». In
effetti, le fonti dell’argomentare del Clown a favore del matrimonio come pentimento si trovano
nell’epistola di San Paolo ai Corinzi (I Cor. 7:14). Apparentemente la Contessa coglie le allusioni alle
Scritture nelle reasons del Clown e accoglie la sua richiesta di matrimonio (I, iii, 37). D’altra parte,
sarebbe errato accentuare separatamente il punto di vista sacro e quello escatologico, dato che la
comicità della scena è chiaramente basata su di un double entendre, e la risposta della Contessa è
deliberatamente ambigua. Il tono sessuale della sua osservazione è che il Clown si pentirà non dei
suoi peccati ma del suo matrimonio, che, come lui stesso ammette, diventerà presto poco più che
spossante fatica fisica, finendo col farlo ritrovare cornuto. Lavatch aggiunge, tuttavia, un delizioso
encomio della sacra confraternita dei becchi, ancora una volta in forma di parodia alla Bottom di San
Paolo (I, iii, 45-50).
Il brano di San Paolo cui ci si rimanda fa parte della cerimonia matrimoniale elisabettiana nel Book of
Common Prayer 1559 (cfr. l’edizione a cura di John E. Booty, Charlottesville 1976, p. 293). Poiché
la parodia profana del sacro intensifica la risposta della audience a ciò che viene parodiato, la facezia
del Clown ci ricorda (nel contesto di una rappresentazione teatrale secolare) che l’unione
matrimoniale è sacra in sé, e riguarda sia la vita fisica che quella spirituale della comunità che ci
circonda. San Paolo conclude: «Grande è il mistero, ma io parlo di Cristo e della congregazione».
C’è da credere che Shakespeare stesso condividesse questo punto di vista nel dramma di cui
parliamo.
8 I, iii, 51 Poysam: nome chiaramente derivato dal francese poisson ‘pesce’, con allusione all’abitudine
papista di digiunare e mangiare pesce invece di carne. Al contrario, il precedente Charbon (nome
derivato dal francese chair bonne ‘buona carne’) allude alla pratica puritana di rifiutare l’ordinanza del
digiuno.