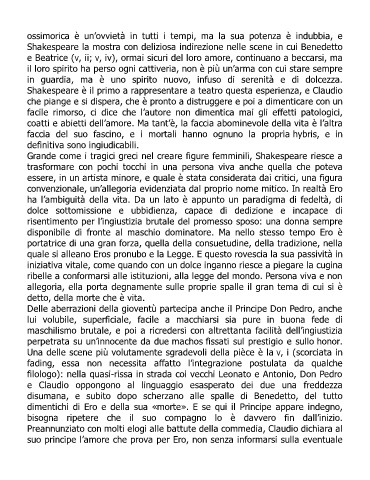Page 1189 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1189
ossimorica è un’ovvietà in tutti i tempi, ma la sua potenza è indubbia, e
Shakespeare la mostra con deliziosa indirezione nelle scene in cui Benedetto
e Beatrice (V, ii; V, iv), ormai sicuri del loro amore, continuano a beccarsi, ma
il loro spirito ha perso ogni cattiveria, non è più un’arma con cui stare sempre
in guardia, ma è uno spirito nuovo, infuso di serenità e di dolcezza.
Shakespeare è il primo a rappresentare a teatro questa esperienza, e Claudio
che piange e si dispera, che è pronto a distruggere e poi a dimenticare con un
facile rimorso, ci dice che l’autore non dimentica mai gli effetti patologici,
coatti e abietti dell’amore. Ma tant’è, la faccia abominevole della vita è l’altra
faccia del suo fascino, e i mortali hanno ognuno la propria hybris, e in
definitiva sono ingiudicabili.
Grande come i tragici greci nel creare figure femminili, Shakespeare riesce a
trasformare con pochi tocchi in una persona viva anche quella che poteva
essere, in un artista minore, e quale è stata considerata dai critici, una figura
convenzionale, un’allegoria evidenziata dal proprio nome mitico. In realtà Ero
ha l’ambiguità della vita. Da un lato è appunto un paradigma di fedeltà, di
dolce sottomissione e ubbidienza, capace di dedizione e incapace di
risentimento per l’ingiustizia brutale del promesso sposo: una donna sempre
disponibile di fronte al maschio dominatore. Ma nello stesso tempo Ero è
portatrice di una gran forza, quella della consuetudine, della tradizione, nella
quale si alleano Eros pronubo e la Legge. E questo rovescia la sua passività in
iniziativa vitale, come quando con un dolce inganno riesce a piegare la cugina
ribelle a conformarsi alle istituzioni, alla legge del mondo. Persona viva e non
allegoria, ella porta degnamente sulle proprie spalle il gran tema di cui si è
detto, della morte che è vita.
Delle aberrazioni della gioventù partecipa anche il Principe Don Pedro, anche
lui volubile, superficiale, facile a macchiarsi sia pure in buona fede di
maschilismo brutale, e poi a ricredersi con altrettanta facilità dell’ingiustizia
perpetrata su un’innocente da due machos fissati sul prestigio e sullo honor.
Una delle scene più volutamente sgradevoli della pièce è la V, i (scorciata in
fading, essa non necessita affatto l’integrazione postulata da qualche
filologo): nella quasi-rissa in strada coi vecchi Leonato e Antonio, Don Pedro
e Claudio oppongono al linguaggio esasperato dei due una freddezza
disumana, e subito dopo scherzano alle spalle di Benedetto, del tutto
dimentichi di Ero e della sua «morte». E se qui il Principe appare indegno,
bisogna ripetere che il suo compagno lo è davvero fin dall’inizio.
Preannunziato con molti elogi alle battute della commedia, Claudio dichiara al
suo principe l’amore che prova per Ero, non senza informarsi sulla eventuale